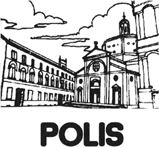Dalla voce appassionata della giovane legnanese Alice Borsatti, il racconto di un’esperienza di vita e di lavoro in Niger, in un centro di salute mentale che accoglie profughi fuggiti da paesi in guerra e che hanno conosciuto le terribili carceri libiche. Una testimonianza ancora più preziosa oggi, quando troppe voci si levano contro il volontariato e la cooperazione internazionale dopo la vicenda di Silvia Romano
Alice Borsatti è una giovane legnanese di ventidue anni che nei mesi scorsi ha vissuto un’esperienza molto particolare: per due mesi ha vissuto a Niamey, la capitale del Niger. Come sanno anche i nostri lettori più distratti, il Niger è un paese chiave nell’Africa subsahariana: possiede ingenti risorse minerarie, preda delle multinazionali (petrolio, uranio, oro), è sede di un’insistente aggressione jihadista e, fatto importante per noi, è terra di transito dei migranti verso la Libia. Il Niger, infatti, confina a settentrione proprio con la Libia e l’Algeria. Oggi sul suolo nigerino sono presenti militari francesi, statunitensi, italiani, tedeschi con lo scopo di aiutare a rafforzare le difese dello Stato e di reprimere le incursioni jihadiste (rafforzate da mercenari giunti dalla Siria) e le attività dei trafficanti di uomini, di armi e di droga. Compito difficile, in un paese per lo più desertico, con una superficie grande quattro volte quella dell’Italia e con una popolazione di diciassette milioni di abitanti. Su questa situazione ha fatto di recente il punto anche il quotidiano «Avvenire», nel numero del 4 marzo scorso. Ad Alice chiedo anzitutto di presentarsi.
Che studi stai facendo?
Frequento il terzo anno del corso di laurea in Scienze dell’educazione (socio-pedagogico) presso l’università di Milano Bicocca. Prima di iscrivermi all’università mi sono diplomata al liceo “Daniele Crespi” di Busto Arsizio con un indirizzo in scienze umane e durante il liceo ho svolto un’attività di volontariato per l’insegnamento dell’italiano ai profughi stranieri ospitati in un centro d’accoglienza di Busto Arsizio. Questo corso di laurea mi ha offerto diversi insegnamenti che mi hanno spinta a scegliere di partire. Tra questi, in particolare, l’esame di pedagogia interculturale e sociale che ci ha permesso di analizzare i cambiamenti socio-culturali avvenuti negli ultimi tempi: abbiamo acquisito le competenze per creare una mappa del territorio; abbiamo raccolto storie e interviste dei migranti; abbiamo svolto analisi approfondite, riflessioni e confronti sulla situazione dell’immigrazione in Italia oggi; e abbiamo affrontato anche il tema di come la politica, di questi tempi, legga e interpreti i fenomeni migratori. È stato interessante, in questo senso, cogliere come molti dei nostri attuali politici cerchino, attraverso i media e facendo leva sulla cronaca, di fomentare un allarmismo diffuso e far credere che “il nero” sia il nemico pericoloso da cui difenderci e che loro, da questo pericolo, ci salveranno. È stato davvero utile renderci conto, poi, di quanto il capitalismo e la globalizzazione abbiano progressivamente distrutto le culture marginali, abbiano alimentato la guerra tra ricchi e poveri, e aumentato drammaticamente le diseguaglianze. Con ripercussioni enormi in termini di violenza e sfruttamento. Ma per quanto riguarda in particolare l’esperienza vissuta in Niger, credo che l’insegnamento universitario a questa esperienza maggiormente connesso sia quello di psicologia clinica di comunità, tenuto dal professor Guido Veronese, psicologo clinico e psicoterapeuta. Il corso tratta dell’applicazione dell’approccio psicologico-clinico ai contesti di comunità e permette di acquisire le competenze per affrontare gravi problemi quali le difficoltà di adattamento e gli stati di disagio e sofferenza delle persone (ad esempio traumatizzate) ponendo la pratica educativa come supporto e strumento per promuovere la resilienza comunitaria. Si tratta di «costruire un senso della comunità e incrementare la coesione sociale, costruire una narrazione collettiva e una conferma dell’esperienza traumatica, ristabilire ritmi e routine della vita e prendere parte a rituali terapeutici collettivi per approdare, infine, a una visione positiva del futuro animata da una rinnovata speranza».
Come mai sei finita in Niger e con chi?
Trovo ancora difficile rispondere con chiarezza a questa domanda. Non è stata una scelta troppo razionale: tutto è avvenuto piuttosto spontaneamente, a partire da una motivazione molto grande a contribuire a rendere il mondo un posto migliore e più pacifico. Grazie ad alcuni corsi universitari, ho iniziato a interessarmi alla nostra situazione socio-politica (al problema del razzismo, all’immigrazione, alla relazione con l’altro e il diverso, all’interculturalità, al problema della cattiva informazione e delle strategie mediatiche che indirizzano negativamente l’opinione pubblica verso posizioni antisolidali e disumane) e progressivamente mi sono sentita sempre più coinvolta, anche emotivamente, sino a decidere, al termine della relazione scritta per la conclusione del percorso di tirocinio propedeutico, di poter essere inserita nell’ambito dei programmi sull’immigrazione. Ed è grazie a Serena, mia compagna di università, che ho scoperto la possibilità di fare questa esperienza in Niger. Lei era già avanti nel percorso (e in contatto, in tal senso con il professor Veronese) ed io, per quanto sentissi l’impegno come troppo grande e gravoso, mi sentivo molto attratta dall’idea (mi sembrava un sogno) e le ho ventilato l’ipotesi di unirmi a lei nell’esperienza. Cosa che è poi avvenuta. All’inizio avevo paura: pensavo di non potercela fare, lontana dalla mia famiglia, dal mio ragazzo, dalle mie amiche; non sapevo se sarei riuscita ad adattarmi a una situazione così diversa e difficile; né se sarei stata capace di sopportare storie di vita così dure da essere quasi inimmaginabili. Ma qualcosa mi ha spinto a provarci. Sono convinta che niente succeda per caso: era il momento di uscire dal nido e mettersi alla prova. E così è stato. Una parentesi di vita arricchente non solo dal punto di vista professionale ma, anche e soprattutto, sotto il profilo umano e personale; qualcosa di unico, che modifica, in qualche modo, il tuo stile di vita e ti fa considerare concretamente l’ipotesi di voler ripetere ancora e nuovamente questo tipo di esperienza. In Niger, con Serena, la mia compagna di università, abbiamo collaborato al progetto Etm (Emergency Transit Mechanism) con l’Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite (Unhcr), con cui il Dipartimento di Scienze della formazione dell’università di Milano Bicocca ha avviato una convenzione per tirocini umanitari per studenti di Scienze dell’educazione. In particolare abbiamo affiancato degli operatori sociali all’interno di un centro di salute mentale in cui erano ospitate circa quaranta persone tra uomini, donne e bambini, e abbiamo avuto la possibilità di osservare e conoscere la realtà di altri centri e altri siti di accoglienza di profughi provenienti dalle carceri libiche e fuggiti dalle guerre in corso negli stati confinanti. La maggior parte di loro desidera tornare nel proprio paese d’origine; decide di fuggire, rischiando la morte, per la sola speranza di sopravvivere e aiutare economicamente le famiglie rimaste a casa.
Com’era organizzata la vostra giornata?
Ogni giorno ci svegliavamo prima delle sette, facevamo yoga con le nostre coinquiline (sul meraviglioso terrazzo di casa a Niamey), facevamo colazione e alle otto salivamo sul pulmino che ci accompagnava al centro di salute mentale dove eravamo state inserite per osservare, ricercare e sperimentare pratiche educative. Qui ci siamo occupate, in particolare, di creare un momento “scuola” per i bambini (di età compresa tra due e nove anni), figli di donne e uomini fuggiti da paesi in guerra e che hanno conosciuto le carceri libiche. Siamo state affiancate da un operatore del centro che, fin da subito, ci ha reso partecipi, per quanto possibile, delle diversissime situazioni dei piccoli. Appena arrivate, la mattina, eravamo accolte dalle loro corse verso di noi, dai loro abbracci e sorrisi: erano sempre felici di iniziare, e questo loro entusiasmo ci aiutava non poco a partire con la carica necessaria per affrontare la giornata. Ci riunivamo in una stanza, spesso mettendoci in cerchio seduti sulle sedie o per terra: s’iniziava con i saluti, le canzoni e poi il dialogo tra loro. Può sembrare banale, ma anche questo è stato molto difficile perché i bambini avevano età e origini molto diverse, non parlavano la stessa lingua e alcuni di loro non erano neppure andati mai a scuola. Dopo queste attività proponevamo spesso dei giochi che coinvolgevano il corpo e il muoversi: i bambini sentono moltissimo l’esigenza di correre, urlare, saltare e ci sembrava giusto e necessario dar loro spazio per sfogarsi. Successivamente lasciavamo che fossero liberi di esprimersi attraverso il disegno, alle volte libero, alle volte con consegne più precise che mirassero, ad esempio, alla comprensione del presente e del passato e ai sogni sul proprio futuro. Quest’attività era spesso accompagnata dalla musica, che loro apprezzavano sempre. Alcune volte abbiamo proposto dei lavoretti manuali con cartoncini colorati, forbici e colla. Altre volte abbiamo utilizzato i giochi in scatola messi a disposizione dal centro (molto efficaci per far sperimentare loro la sconfitta, il fallimento e la gioia condivisa di una vittoria non propria).
Come proseguiva la giornata?
Alla fine della mattinata lasciavamo che i bambini si autogestissero liberamente con alcuni giochi portati dall’Italia come Lego, macchinine, Barbie, animali di plastica o pezza. Un momento prezioso per osservarli, comprenderli meglio e lavorare sul primo obiettivo che c’eravamo poste: creare gruppo, insegnare loro il valore della collaborazione, della cooperazione, della solidarietà. E quando ciò accadeva, quando tutti i bambini giocavano insieme, era come una magia; e per noi una straordinaria gratificazione. Verso le tredici si tornava a casa per il pranzo e alle quindici eravamo di ritorno al centro, dove continuavamo a proporre attività diverse ma tutte tese a far sentire questi bambini sinceramente ascoltati, accuditi, stimolati e incoraggiati a crescere come esseri pensanti, consapevoli e quanto più sereni possibile. Spesso, nel pomeriggio, c’erano dei servizi esterni già organizzati e programmati come danza, origami, teatro e taekwondo. La giornata finiva intorno alle diciassette, con noi esauste, prosciugate dalle energie infinite dei piccoli ma felici di aver condiviso tempo prezioso con loro. Nonostante la fatica e i racconti di storie di vita indescrivibili, ogni mattina sentivo forte la motivazione di tornare al centro, per e con le persone che lo abitavano.
Quale situazione complessiva hai trovato nella capitale del Niger?
All’inizio ero un po’ spaesata e la situazione che ho trovato mi è parsa abbastanza caotica. Dopo qualche giorno di assestamento ci hanno fornito le informazioni necessarie per cavarcela in città (dove trovare l’acqua, dove fare la spesa, dove poter ritirare contante) e abbiamo fatto un briefing sulla sicurezza, in cui ci hanno spiegato le rigorose direttive che riguardavano i confini territoriali da non oltrepassare e il coprifuoco da rispettare, informandoci altresì della posizione strategica del Niger e della situazione socio-politica degli Stati confinanti. Ci sono stati illustrati i rischi connessi alla criminalità e al terrorismo, ma siamo state subito rassicurate sul fatto che le misure di sicurezza avevano proprio l’intento di contenere questi rischi. Dopo le prime difficili settimane tutto è cambiato ed è subentrato un progressivo vero e proprio innamoramento che, ancora oggi, riesco in qualche modo a rivivere e rievocare grazie al diario giornaliero che scrivevo. Spesso nel tragitto da casa al centro mi prendevo il tempo per osservare quel mondo al di fuori del finestrino dell’auto e spaziare con la mente. Mi sentivo bene, faceva molto caldo, ma neppure quello mi sembrava insopportabile. Il paesaggio era unico, mai costante, la terra era rossa e nei villaggi si vedevano case di paglia e bambini nudi che correvano e giocavano con le gomme delle ruote facendole rotolare. Il cielo era azzurro e così vicino che sembrava mi abbracciasse. Le persone erano sorridenti, ci salutavano tutte. Sono gentili lì, e sembra che quanto meno hai, meno fatica fai a dare! Il centro di salute mentale era diventato ormai un ambiente familiare, i bambini erano diventati parte della mia quotidianità, dei miei pensieri e del mio cuore. La cosa più difficile di questo lavoro, secondo me, è la separazione (indispensabile) dalle persone che si sono incontrate. Per me è ancora una separazione solo parziale: sento che le persone che ho incontrato sono parte viva del mio cuore e dei miei pensieri. Mi auguro che anche noi possiamo aver lasciato loro qualcosa d’importante che possano conservare, senza aver necessariamente bisogno della nostra presenza. In questo caso avremo fatto bene il nostro lavoro.
Ovviamente l’Africa è diversissima rispetto all’Europa e all’Italia. Non c’è bisogno di andare nel Niger per saperlo. Ma quale differenza ti ha colpito di più?
In Niger le persone hanno un’altra concezione del tempo, la vita non è frenetica come da noi, tutto è più rilassato; ma le attese sono talvolta così lunghe da far sorgere in noi la domanda spontanea su cosa sia davvero il tempo e se non sia giusto migliorare la nostra capacità di essere pazienti. Un aspetto che mi ha fatto molto soffrire è l’enorme disparità tra ricchi e poveri: ci sono scuole private, grandi hotel, ristoranti internazionali, enormi case a più piani con marmi e giardini, e poi ci sono i poveri che vivono in piccoli villaggi, in case di paglia attorniate da grandi cumuli d’immondizia. I più benestanti hanno mucche, capre e galline e si vedono diverse bancarelle di spiedini di carne o di frutta e verdura, anche se la loro coltivazione è limitata ai territori presso le sponde del fiume Niger. In Niger c’è un’enorme produzione di miglio e per questo molti piatti tipici sono a base di questo cereale. L’artigianato è molto praticato, c’è anche un museo dell’artigianato all’interno dello zoo. Qui molti artigiani lavorano il cuoio, il legno, i tessuti e i metalli e vendono le loro creazioni. In alcune strade della città ci sono diverse sartorie e si sente nitido e forte il tipico il rumore della macchina per cucire. Niamey è una città molto trafficata e le strade sterrate sono piene di macchine e motorini.
Cosa ti ha insegnato questa esperienza?
Questa esperienza mi ha dato tanto. Come cittadina del mondo mi ha insegnato quanto sia importante contribuire al benessere di tutti e di quanto sia vero che siamo tutti implicati l’uno con l’altro (forse la situazione italiana che stiamo vivendo può dirci qualcosa in questo senso e risvegliare questo sentimento). Mi ha fatto capire il valore e l’importanza di essere testimoni diretti di quello che succede così lontano da noi: spesso ciò che non ci coinvolge direttamente lo guardiamo con disinteresse, affidandoci passivamente alle notizie e alle informazioni (spesso strumentalizzate) di telegiornali e politici. Ora ho compreso più profondamente quanto sia importante recuperare informazioni vere e di quanto altrettanto importante sia renderle disponibili e divulgarle. Dal punto di vista personale, l’esperienza a Niamey mi ha insegnato a ridimensionare i problemi quotidiani, a essere ottimista, a gestire le mie emozioni, a conoscermi più profondamente, a mettere in discussione le mie risorse e i miei limiti. Mi ha insegnato a essere grata per ciò che ho e per ciò che ancora posso imparare e fare. Mi ha insegnato quanto sia terapeutica la gentilezza e la generosità; quanto si possa imparare dai bambini, da modi di vivere e pensare diversi dai nostri e quanto può essere forte l’essere umano che sopravvive nonostante le atrocità subite che lo segneranno per l’intera esistenza. Mi ha insegnato quanto è forte l’umanità tutta, soprattutto se insieme lotta per un fine comune, per il benessere collettivo. Mi ha illuminata su quanto sia fondamentale cercare di vivere una vita più sostenibile: dal piccolo gesto di chiudere il rubinetto dell’acqua mentre ti lavi i denti, al limitare gli spostamenti in macchina e a smetterla di comprare abbigliamento inutile, che alimenta solo consumismo e sfruttamento. Mi ha insegnato che ho ancora tanto da vedere, comprendere e imparare. Per questi motivi, per questi insegnamenti, coltivo forte l’idea di tornare ancora in Niger o andare in altri paesi in cui c’è un grande bisogno di visibilità, cura e professionalità. Non ho idee precise sugli studi successivi e sull’ambito specifico del mio lavoro da educatrice. Sicuramente desidero continuare a formarmi, proseguendo con gli studi magistrali e poi vorrei lavorare con persone in situazioni di disagio, vulnerabilità e marginalità.
Verrebbe voglia di fare mille altre domande ad Alice e magari di dare una sbirciatina al suo diario del Niger. Ma ci dobbiamo accontentare delle importanti cose che ci ha detto. Tante andrebbero meditate e discusse. Intanto, però, sappiamo che a Legnano esiste, con Alice, una preziosa risorsa in più: per la città e per il mondo.
Giorgio Vecchio