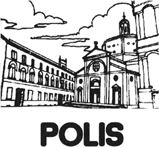La cronaca sempre più spesso ci racconta di casi estremi, esistenze tribolate dinanzi alle quali familiari, medici o giudici sono chiamati a prendere decisioni talvolta estreme. È possibile definire dei “criteri” di scelta? “Dentro una buona relazione – afferma il bioeticista Picozzi – sarà possibile scoprire la decisione buona”
Le recenti vicende che hanno visto coinvolti piccoli bambini e la controversia tra genitori ed equipe sanitaria sulla miglior cura da offrire loro, insieme all’approvazione in Italia della legge sulle disposizioni anticipate di trattamento (Dat) hanno riproposto all’attenzione dell’opinione pubblica il tema dell’esperienza della sofferenza e delle scelte sul fine vita. Ci proponiamo di offrire alcune riflessioni che possano aiutare ciascuno a maturare un giudizio ponderato.
La questione seria: le domande alla fine della vita. Le parole che pronunciamo ci istruiscono sul modo buono di vivere le fasi finali della vita. La vita insegna alla vita. Al “dottore faccia di tutto/non mi/non lo abbandoni” del paziente e dei suoi familiari corrisponde l’impegno del medico: “le prometto che starò dalla sua parte”. “Tu non morrai”: in questa frase si esprime l’attaccamento, la dedizione alle persone a cui vogliamo bene.
A queste espressioni fanno da contrappeso queste altre: “non voglio soffrire”, “non fatelo soffrire”; per il medico e gli operatori sanitari possiamo tradurre “fino a quando andare avanti con i trattamenti?”
Queste affermazioni, in apparenza contrapposte, esprimono l’impegno da una parte di non abbondonare il paziente e dall’altra parte di non accanirsi, di non ricorrere a trattamenti inutili, rifugiandosi nelle tecnica per non affrontare la domanda che ti chiama in causa quale figlio, genitore, medico.
Possiamo ritradurre la diade nel rapporto tra resistenza (al male, alla malattia, alla sofferenza) e resa (ai limiti della medicina e della vita umana). Ma fino a quando resistere? E quando arrendersi?
La proporzionalità di un trattamento. Quali i criteri per giudicare una cura non più proporzionata, che diventa quindi legittimo sospendere?
Un primo criterio di proporzionalità chiede di integrare gli aspetti clinici con la storia personale del paziente, ovvero il giudizio sulla qualità di vita. Ciò comporta che il giudizio non può prescindere dagli aspetti clinici, dai numeri: è necessario conoscere le probabilità di successo di un intervento insieme alla speranza di prolungamento della vita che esso comporta. Ma se ciò è necessario, non è sufficiente: occorre valutare la ricaduta di questi numeri sulla vita del paziente, a cui prioritariamente compete la decisione finale. Questa dialettica tra dato oggettivo e valutazione soggettiva riconosce che da una parte la valutazione del soggetto non può essere arbitraria (è sempre in riferimento ad una data condizione clinica), dall’altra che applicare modelli teorici a prescindere dalle condizioni effettive del paziente è astratto e non rispettoso della sua persona. Anche nelle legislazioni che consentono l’eutanasia, la richiesta del paziente di essere aiutato a morire può essere accolta solo se vi sono specifiche condizioni cliniche.
Un secondo elemento del giudizio di proporzionalità è la questione del tempo, ovvero più precisamente la nozione di terminalità: ossia quando la prognosi è inferiore ai 6 mesi la richiesta di sospensione dei trattamenti appare, almeno in via generale, legittima sia eticamente che giuridicamente. Tale posizione è certamente ragionevole: ciò che rileva in questi casi, caratterizzati da una patologia irreversibile a prognosi infausta, è il modo in cui ciascuno ritiene sia meglio vivere gli ultimi giorni della propria esistenza. Non ci si espone a possibili abusi o arbitri, essendo le caratteristiche della patologia una garanzia oggettiva. Resta però l’interrogativo: se la terminalità è un elemento condiviso e garantista, può diventare un criterio esclusivo, oltre il quale ogni trattamento deve essere considerato proporzionato? Il rischio di potenziali abusi è tale da precludere la possibilità di accettare la sospensione dei trattamenti quando non vi sia una condizione di terminalità? Riteniamo sia necessario interrogarsi se sia eticamente accettabile la sospensione anche quando il soggetto non si trovi in uno stato di terminalità.
Tre criteri. E questo per diverse ragioni. La prima è che questo criterio clinico appare oggi troppo restrittivo. La tecnologia consente di prolungare per lungo tempo situazioni cliniche molto pesanti, in cui il soggetto e i suoi familiari, pur avendo resistito, non hanno più le risorse morali, prima che fisiche ed economiche, per proseguire. Si pensi alle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica o in stato vegetativo.
Poiché il giudizio di proporzionalità – ed è la seconda ragione – è una relazione tra condizioni cliniche e valutazione esistenziale del paziente, come abbiamo detto nel punto precedente, il criterio della terminalità fa pendere indebitamente tale relazione a favore della clinica. Per cui più che di terminalità occorre riferirsi ad una patologia di cui il soggetto è affetto sia irreversibile, a prognosi infausta, ingravescente.
Un terzo criterio attiene agli oneri che il trattamento può causare sul paziente e sulla sua famiglia e in taluni casi sull’intera collettività. Per oneri ci si riferisce a quelli di natura psico-fisica, anche se in determinati contesti non si può non tener conto anche di quelli economici. La questione fondamentale riguarda i soggetti su cui ricadono tali oneri. Se è giustificabile che un paziente ritenga per lui – il grado di resistenza varia da persona a persona – non più sopportabile sotto il profilo fisico un determinato trattamento per gli effetti collaterali connessi (si pensi alle terapie neoplastiche), è altresì accettabile che il suo rifiuto sia dovuto agli oneri (anche in questo caso in termini primariamente esistenziali) che la sua assistenza comporta per i suoi familiari?
E nel caso di un paziente incompetente, quale peso attribuire alla decisione di sospensione portata avanti dai tutori, adducendo come criterio gli oneri della cura? Si ricordi, come abbiamo sottolineato, che nella cura dell’altro, anche ove lui non mi riconosca, ne va di me. Ne va di me anche se lui non sa più di me. Il criterio degli oneri ha un ruolo nella definizione di proporzionalità di un trattamento.
Quando sono presenti questi criteri, una patologia irreversibile, a prognosi infausta, ingravescente, all’interno di una valutazione tra dato clinico e storia del paziente, a fronte di oneri non più sopportabili la richiesta di un paziente di sospendere un trattamento appare eticamente accettabile – non si tratta di un atto eutanasico, ma rinuncia a trattamenti sproporzionati – e deontologicamente coerente con la promessa di cura del medico. In questo caso, ricordando che ne va del medico in quanto medico e in quanto persona, la sospensione del trattamento si mostra quale forma buona del prendersi cura dell’altro, nella declinazione tra resistenza e resa, rispettosa della storia del paziente.
Cosa fare? Quando ci viene chiesto: cosa fare? noi rispondiamo: raccontami la tua storia o raccontaci sua storia, ove il paziente non sia più in grado di esprimersi. La storia personale non si aggiunge a una soluzione già individuata a monte di essa, ma esattamente a partire da essa che è possibile individuare una soluzione buona. Non si sa da subito fino a quando resistere, né può essere dedotto da una linea guida o raccomandazione, ma dentro una storia si scopre quando arrendersi. La vita insegna alla vita.
Dentro una buona relazione sarà possibile scoprire la decisione buona. Senza una relazione non si è in grado di scegliere. Ciascuno ha un parola da dire, non un veto da porre. Ne va di ciascuno. Non si può essere neutri o nascondersi nella tecnica. Per questo non è importante solo ciò che decido – accetto o rifiuto un determinato trattamento – ma il processo relazionale che porta a compiere determinate scelte. Si pensi al dibattito suscitato prima e dopo l’approvazione della legge sulle Disposizioni anticipate di trattamento. L’autonomia, ovvero la scelta del paziente, è parola ultima, non prima od unica.
La difficile decisione. Due riflessioni conclusive. Sono consapevole che la mia proposta lascia spazio alla discrezionalità. Ovvero, a partire dalla stessa condizione clinica, più opzioni eticamente accettabili sono possibili, essendo diverse le storie personali. I criteri che abbiamo segnalato, evitando di cadere nell’arbitrio e nel relativismo, rappresentano quello spazio di libertà, rispettoso delle storie individuali, all’interno del quale è possibile scegliere l’azione buona. Il tempo della malattia è anche tempo di libertà.
Talvolta è veramente difficile decidere. Se potessimo spostare a domani la scelta, lo faremmo volentieri. Ma come ammoniva Aldo Moro, “oggi dobbiamo vivere, oggi è la nostra responsabilità”. Per vivere quella che Papa Francesco chiama la “prossimità responsabile” nelle situazioni di grigio, dove non è chiaro quale sia la soluzione eticamente buona, può essere necessario l’aiuto di un soggetto esterno, ma non estraneo a quella determinata storia, che affianchi il medico, il paziente, la famiglia, senza a loro sostituirsi. Non si vuole e non si può fuggire dalle proprie responsabilità: ma non si vuole essere lasciati soli. Da soli non si resiste nei momenti difficili della vita.
Mario Picozzi
docente di Bioetica
Università dell’Insubria
Varese