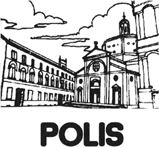Una fragile solidità: quest’ossimoro sembra essere un’espressione corretta per la nostra settantenne Repubblica, ma potremmo anche usarne altri, come una “una ricca povera” o “una giovane anziana” e via dicendo, magari invertendo tra loro i termini. Si tratta di ricorsi retorici che celano però profonde verità storiche su come la Repubblica ha avuto i natali e su come si è sviluppata in questo settantennio. Potremmo discuterne a lungo e sarebbe bello poterlo fare invece di perdere tempo a seguire gli sterili battibecchi della nostra classe politica.
Nel 1946, appena usciti da un ventennio di retorica patriottica e guerresca, oltre che un militarismo ciarliero e impotente, gli italiani e le italiane desideravano una concretezza che rispondesse ai bisogni del tempo e agli stomaci vuoti, ma che non rinnegasse le grandi passioni di quanti – una parte, certo, della popolazione – stava ancora lottando per un sistema politico di giustizia e di libertà.
Né spirito eroico né retorico
Molte testimonianze coeve sono dunque concordi nell’indicare la mancanza di ogni spi-rito eroico e retorico nella nascita della Repubblica. Anzi, a prevalere sembrava essere un carattere dimesso, quasi che i repubblicani avessero paura di vincere e di manifestare la propria soddisfazione. Era questa, forse, una garanzia di maggiore durata. Scriveva per esempio Corrado Alvaro che «la Repubblica è nata dimessamente. È forse la prima volta che un regime italiano nasce all’italiana, senza eroici furori, senza deliri di grandezza. La Repubblica italiana è nata come una creatura povera, com’è povero il paese; assistito da parenti poveri». E un altro uomo, che di lì a poco avrebbe giocato un ruolo importante nella stesura della Costituzione, Pietro Calamandrei, rincarava la dose, spiegando che non era «mai accaduto nella storia, che una Repubblica si sia fatta con paziente lentezza e con il re sul trono», aggiungendo: «Ecco la nostra Repubblica: non improvvisata, non balzata su in un giorno di torbida passione: Repubblica voluta, meditata, paziente, ragionata […] destinata a durare secoli». Un altro grande del tempo, Ignazio Silone, ammetteva: «Più di uno è sinceramente costernato per la sobrietà, la semplicità, la prosaicità delle parole che hanno salutato la nascita della prima Repubblica Italiana».
Insomma: la grande festa, almeno al centro-nord. era stata quella del 25 aprile e della fine della guerra, più che il 2 giugno, anche per la drammatica lentezza nell’ufficializzazione dei risultati del referendum e per le prime delusioni che andavano affiorando tra gli italiani (a sud, l’Uomo Qualunque di Giannini aveva iniziato la sua rapidissima parabola ascendente).
Quindi: fastidio per la retorica e necessità impellenti, ma pure difficoltà nel riallacciarsi a qualche precedente storico gradito. Per i cattolici “repubblica” era addirittura una parola quasi blasfema, perché rimandava alla rivoluzione francese o a quella sovietica o al Messico o ancora alla Spagna. Per tutti un padre della patria come Mazzini era poco ap-petibile come modello: non alla Chiesa, ma neppure ai comunisti (Mazzini era stato av-versario di Marx ai tempi della prima Internazionale…). E poi, repubblicani, erano stati pure i fascisti di Salò.
Insomma: sì, volentieri e con convinzione, alla cacciata della monarchia, ma senza attri-buire alla neonata Repubblica più importanza del dovuto.
Simboli “deboli” e curiosità
Questo senso di fragilità o, se si vuole, di umiltà, è riscontrabile anche tramite l’osservazione delle vicende che portarono all’adozione dei simboli tipici di uno Stato nazionale: la bandiera, lo stemma, l’inno.
Per quanto riguarda la bandiera, non sussistevano dubbi. Nessuno alla Costituente pose in discussione il Tricolore, sgombrandolo da simboli di sorta e riportandolo alla sua più nuda ed efficace semplicità. Semmai fa specie notare che l’art. 12 («La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni») non sia altro che la traduzione letterale dell’art. 2 della Costituzione fran-cese del 27 ottobre 1946, mantenuto in seguito anche nella Costituzione del 1958: ma chi ha copiato chi?
Va notata un’altra particolarità: i colori verde-bianco-rosso furono inseriti nei simboli dei partiti “estremi”, più che in quelli di governo (con l’eccezione del Partito liberale erede diretto del Risorgimento). Solo Partito comunista e Movimento sociale italiano, in vario modo, li inserirono nei propri simboli, mentre tutti gli altri, dai socialisti ai monarchici, optarono per altre soluzioni cromatiche.
Più tragicomica fu la vicenda relativa allo stemma repubblicano, perché si dovette pas-sare per due concorsi pubblici, entrambi vinti dall’artista Paolo Paschetto. Il primo boz-zetto fu giudicato però irricevibile dal governo (e dalla stampa), raffigurando una cinta muraria subito paragonata a una tinozza. In fretta e furia fu indetto un nuovo concorso, quello che portò infine alla stella e alla ruota dentata che tutti conosciamo. “In fretta e furia”, è il caso di dire, perché gli americani erano arcistufi di ricevere documenti dal governo italiano sui quali troneggiava, non sempre sovrastampato, persino il fascio! Nell’Italia povera di allora, nessuno aveva voluto buttare al macero la vecchia carta in-testata.
Completamente comica fu invece la vicenda che portò all’adozione dell’inno nazionale. All’indomani del 2 giugno si aprirono i primi dibattiti pubblici, con proposte più o meno stravaganti pubblicate sui giornali o mandate al governo. Finalmente il 12 ottobre 1946 il Consiglio dei Ministri affrontò il problema e ne diede notizia in termini alquanto lapidari, tant’è che il giorno dopo i quotidiani riportarono poche righe del comunicato stampa ufficiale e non altro: «Su proposta del Ministro della Guerra si è stabilito che il giuramento delle Forze Armate alla Repubblica e al suo Capo si effettui il 4 novembre p.v. e che, provvisoriamente, si adotti come inno nazionale l’inno di Mameli». Insomma l’affare fu sbrigato in pochi minuti e senza troppe riflessioni. Quel «provvisoriamente» è in vigore ancora oggi, 70 anni dopo, a riprova che in Italia nulla è più definitivo del provvisorio.
Ma il bello venne dopo. Nessun ministro si preoccupò di emanare una circolare che formalizzasse meglio la decisione presa, così che nelle settimane successive lo stesso Ministero degli Esteri dovette chiedere lumi alla Presidenza del Consiglio sulla base delle notizie apparse sui giornali, mentre ai vari organi dello Stato continuavano ad arrivare proposte di spartiti musicali e di testi. Così l’incertezza e la confusione si perpetuarono: dai nostri comandi militari e dalle nostre ambasciate continuarono ad arrivare al governo richieste di chiarimento. Ci si mise pure, nell’aprile 1948, il presidente del Coni, Giulio Onesti, per sapere «quale musica deve essere adottata come inno ufficiale italiano» in occasione della XIV Olimpiade a Londra: evidentemente si contava su qualche medaglia d’oro (che poi arrivò). Ma, sempre nella capitale britannica, il 6 maggio 1959, allo stadio di Wembley, davanti agli azzurri e ai bianchi d’Inghilterra schierati per un’amichevole, fu suonata la Marcia Reale invece dell’Inno di Mameli. Ne nacque naturalmente un putiferio (per inciso: finì 2-2 e in porta c’era Buffon, Lorenzo ovviamente).
Si potrebbe dire che, complessivamente (e anche per i motivi già detti) non ci fu la per-cezione dell’importanza di un simbolo riconosciuto e amato per la nuova creatura re-pubblicana, dimenticando che in greco συμβολον (súmbolon) trae origine da parole che indicano il “gettare insieme”, l’unire (al contrario del diavolo, la cui etimologia rimanda al “gettare attraverso”, al dividere). Non fu un caso, forse, se gli italiani si affezionarono di più ai simboli religiosi o a quelli di partito. Ma questo richiederebbe ben altro spazio per ragionare sullo sviluppo del senso dello Stato e del senso della Patria in questi 70 anni.
Una resistenza inattesa
Eppure la Prima (e unica finora) Repubblica italiana ha retto. Essa ha superato come du-rata lo Stato liberale (62 anni dal 1861 al 1922), per fortuna!, ha surclassato il regime fascista (21 anni dal 1922 al 1943). Nessuno contesta oggi la forma repubblicana, anche se ci si accapiglia sulle strutture costituzionali portanti e sulle modalità dell’esercizio del potere politico, oltre che sul progetto riformatore di Matteo Renzi.
Non è il caso qui di soffermarsi sulle infinite prove e tragedie che hanno segnato questi sette decenni: dalla guerra fredda al terrorismo, dall’eversione nera all’eversione mafiosa, dalle tragedie naturali inevitabili a quelle provocate dall’imperizia o dalle colpe dell’uomo, dal degrado educativo alla persistente voglia di delegittimazione dell’avversario e via discorrendo.
Vi è da chiedersi se in questa capacità di perpetuarsi non vada ritrovato qualche effetto della saggezza dei nostri Padri e delle nostre Madri (quando ci ricorderemo di più di loro) della Repubblica e della Costituente. Forse siamo ancora in tempo per non disperdere un patrimonio di saggezza politica e di stile umano misurato (pur negli insulti feroci dei tempi della guerra fredda).
Bisogna dunque tornare a quel 1946 per trarre qualche lezione di vita valida anche per oggi, stretti come siamo tra renzismo, antirenzismo e grillismi o leghismi vari.
La classe politica che ci regalò la Repubblica e la Costituzione nel suo insieme era composta da uomini probi e sobri anche nei comportamenti personali: educata in larga parte alla “scuola” del carcere e del confino oppure dell’esilio, essa aveva la consapevo-lezza dei limiti posti dalla situazione concreta alla dialettica politica. Né De Gasperi né Togliatti e neppure Scelba – per esemplificare – intendevano portare il conflitto politico alle estreme conseguenze e quindi a un punto di non ritorno. Vi era, tra di loro, un im-plicito riconoscimento reciproco.
Probabilmente pesava in loro anche una comune formazione patriottica, favorita dallo stesso fascismo ma contenente elementi e temi pre-fascisti: il mito di Garibaldi e quello del Piave, il Risorgimento e la Grande Guerra, l’Italia povera dell’emigrante e dell’artista, del santo cattolico e dell’umile lavoratore…
L’assenza di retorica collimava del resto con le attese della gente, stufa di parole alate e di conflitti, e pronta a ripiegare sul privato e sulla ricerca del benessere. La descrizione del presidente Einaudi fatta dal «Corriere della Sera» in occasione del 2 giugno 1948 è esemplare: il giornale milanese parlava di un «uomo piccolo e magro, in un abito nero di borghese, che faceva un gradino per volta, appoggiandosi al bastone, piegandosi ad ogni passo da una parte», aggiungendo: «C’era una grandiosità, nella sua modestia, nella sua semplicità, perfino nel¬l’andatura dimessa, una grandiosità patetica e gentile, che lo avvicinava tanto al sentimento dei presenti e ne provocava l’affettuosa simpatia, quanto una figura diversa, con un diverso abito, ne avrebbe in quel momento forse suscitato la freddezza».
C’era dunque – forse – un senso della realtà più diffuso di quanto si pensasse e si pensi anche oggi. In occasione del 2 giugno 1949 un giornalista cattolico (e conservatore), mons. Ernesto Pisoni, direttore de «L’Italia» di Milano ammonirà: «In fin dei conti que-sta Repubblica italiana siamo noi, è l’Italia. Uno può essere più o meno fiero della Re-pubblica e sta bene, può trovare che il suo emblema araldico con stella e ruota dentata è troppo simile a un marchio di biciclette di infima qualità, e siamo d’accordo, ma non ha il diritto di seminare consapevolmente scontento, inquietudine, vaneggiamenti su im-possibili ritorni […] Dobbiamo a noi stessi – a noi in quanto italiani – un senso di mag-gior serietà e di maggior rispetto per le nostre istituzioni».
Giorgio Vecchio